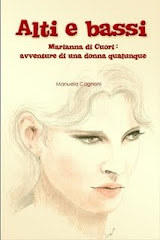«Nel mezzo dell'inverno ho scoperto infine che esisteva in me un'estate invincibile.»
"Ritorno a Tipasa" è forse il più famoso dei saggi che compongono "L'estate", uno dei libri più belli di Camus, quello in cui esprime il suo amore e la nostalgia per l'Algeria («Speravo, credo, di ritrovare una libertà che non potevo dimenticare»).
È un viaggio per le città algerine, che parte da Orano, il luogo in cui in seguito avrebbe ambientato "La peste", e fin dall' inizio si ha l'impressione di aggirarsi tra le strade soleggiate di una città di pietre antiche, di sassi rossi, di polvere. Una città sul mare ma che, invece di aprirsi verso il mare, «volta le spalle al mare, che si è costruita attorno a se stessa, come una lumaca.» È un labirinto e il Minotauro si rivela essere la noia, che trattiene i suoi abitanti e li divora.
Le città algerine sono simili a quelle italiane e a quelle spagnole, ma sono «città senza passato.» Eppure tra queste poche pagine si consuma la nostalgia per un tempo lontano, per tutte le cose che non ritornano, per gli anni giovani che sono persi.
«Sono cresciuto sul mare e la povertà mi appariva fastosa, poi ho perso il mare, allora tutti i lussi mi sono apparsi grigi e la povertà intollerabile.»