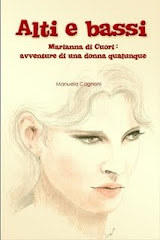Ero a casa e stavo guardando una delle partite terribili dell’Italia ai mondiali, non ricordo quale però sicuramente non l’ultima, che non ho visto ma i cui risultati mi hanno raggiunto in ufficio, differiti di qualche secondo rispetto al momento in cui avvenivano. Era quindi una di quelle partite in cui ancora si sperava che la squadra si risvegliasse e, al tempo stesso, ci si innervosiva per quel mancato risveglio. Anche chi, come me, di calcio non capisce niente e i mondiali significano solo delle allegre serate d’estate con gli amici.
E’ stato quindi mentre cenavo e guardavo i mondiali, osservavo gli omini blu che rincorrevano la palla vicino alla porta avversaria e poi cercavano di allontanarla dalla propria, che mi sono ricordata di quel pomeriggio lontanissimo in cui ero una bambina che giocava a palla con altri bambini, nel giardino della casa di mia zia.
Ad un certo punto avevamo smesso di giocare e io ero entrata in casa, trovando il soggiorno immerso nella penombra e in un silenzio assoluto, che mi intimidiva e mi infastidiva, mentre tutti fissavano la televisione.
“Vieni,” bisbigliò mia madre prendendomi in braccio e sfiorandomi il viso con i suoi capelli neri lunghi, mentre mi faceva sedere sulle ginocchia. “Guarda, quelli azzurri sono i nostri omini, vedi che corrono e cercano di avvicinarsi alla porta degli altri? Devono buttare dentro la palla,” mi disse, spiegandomi così le poche nozioni che aveva di calcio e che sono tuttora le poche che ho io.
Ho scoperto solo molti anni dopo che erano i mondiali del ‘74 e che l’Italia non ne uscì per niente bene. Questo in parte spiega la sensazione che il silenzio di quel giorno fosse non solo concentrato ma anche piuttosto irritato.
Il resto del weekend invece non andò così male, la casa che mia zia aveva affittato aveva parecchie stanze e in ogni stanza c’era un campanello, il cui numero appariva su una specie di monitor in cucina, cosa che mi divertiva molto e che era una fonte continua di nuovi giochi. Uno su tutti quello dell’ospedale.
Ritornai in quella casa due anni più tardi, in luglio, per due lunghe settimane che restano uno dei periodi più allegri e felici della mia infanzia.
Partii con la zia all’alba di una mattina in cui le strade di Milano erano deserte e il radiotaxi correva veloce verso la stazione centrale. Gli amici che dovevano partire con noi e con i quali dovevamo dividere la casa, arrivarono invece tranquillamente, un buon quarto d’ora più tardi, rilassati e sorridenti.
“Buongiorno!” dissero continuando a sorridere, mentre erano ancora sulla scala mobile.
“Buongiorno un corno!” li accolse irritata la zia.
Quello fu l’inizio della vacanza e della convivenza.
“Voglio andare a Forte dei Marmi,” ho detto, mentre cenavo e guardavo la terribile partita dell’Italia, senza capire niente se non che gli omini blu dovevano cercare di avvicinarsi il più possibile alla porta avversaria e spingere dentro la palla.
Il compagno della mia vita ha staccato gli occhi dalla televisione per un secondo, giusto il tempo di lanciarmi un’occhiata stupita, chiedendosi perché mai mi fosse venuto in mente Forte dei Marmi mentre era in corso una schifosissima partita, che la nostra squadra stava anche rischiando di perdere. Credo che niente potesse essere più lontano dalla sua mente di Forte dei Marmi, un paese dove non era mai stato e dove nemmeno aveva voglia di andare. Del resto anch’io non andavo a Forte dei Marmi da vent’anni. Diciannove per l’esattezza, visto che l’ultima volta è stata in quel bruttissimo e lontano 1991. Diciannove anni… lo stavo realizzando solo adesso e mi chiedevo anche perché fossi stata così tanto tempo senza tornarci. Eppure è un posto dove sono stata felice, anche nel 1991 a Forte dei Marmi ero stata bene. E mi è capitato di passarci spesso, in questi diciannove anni. Invece niente, gli anni sono passati e non mi sono mai fermata. Ci sono parecchie cose di cui mi sto accorgendo che non faccio da secoli senza sapere il perché. Forse semplicemente perché questi anni sono passati molto velocemente, troppo velocemente, e io non ho fatto in tempo.
E’ stato così che siamo passati da Forte dei Marmi e siamo usciti dall’autostrada, in una domenica caldissima, mentre il navigatore ci dirige con voce imperiosa verso il centro e ci porta dritti davanti alla Capannina. E vista così, diciannove anni dopo, di giorno, con il sole, la Capannina mi sembra improvvisamente bella e allegra.
Perché in realtà la Capannina è uno dei posti in cui mi sono annoiata di più in vita mia, ricordo ancora quell’orribile sonno che mi assaliva mentre mi trascinavo da un tavolo all’altro, da una sala all’altra. Ogni volta che sono stata alla Capannina desideravo la mia camera d’albergo e il mio comodo letto e mi chiedevo quanto tempo sarebbe passato prima di poterci andare, mentre accanto a me i miei amici sorridevano e si rallegravano per il privilegio di esser entrati gratis anche quella sera.
Preferivo di gran lunga il Caffè Morin, con i suoi divanetti di vimini e l’affogato al caffè che mi sembrava insuperabile.
“Adesso mi prendo subito una polanskaya,” sorrideva felice uno dei miei amici, che per quell’estate venne soprannominato Polanskaya. Ne beveva a litri, di polanskaya, che altro non era se non un miscuglio di vodka, limone e zucchero. Lo guardavo nauseata e mi veniva ancora più sonno e ancora più voglia di affogato al caffè.
Lo racconto al compagno della mia vita e imito la voce del mio amico, mentre calca l’accento sul nome russo.
Il compagno della mia vita sorride e guarda con sufficienza la Capannina.
“Non mi ricordo più dov’era il nostro albergo,” dico. A dire la verità non mi ricordo nemmeno più il nome, sono secoli che non ci penso. “Però mi ricordo che qui vicino c’era il Caffè Morin, mi piacerebbe tornarci, facevano un affogato al caffè buonissimo. Potremmo prenderci un gelato per pranzo…” dico. Se solo mi ricordassi dov’è il Caffè Morin!
Fa un caldo terribile sul lungomare, sotto il sole. E il lungomare in realtà è la parte che mi interessa meno, io vorrei girare per il paese e ritrovare le strade dove ho camminato tanti anni fa. E’ strano, quell’estate, nel 1991, cercavo i luoghi dov’ero stata da bambina, guardavo all’interno di ogni giardino per ritrovare la casa della zia, mentre ora vorrei ritrovare l’albergo e i luoghi di allora, quando avevo ventun anni ed ero arrivata a Forte dei Marmi con tutta la tristezza di quel brutto anno e la voglia di lasciarmela alle spalle.
Ma cosa cercavo quell’estate, a ventun anni, mentre sedevo ad un tavolo di vimini del Caffè Morin, mangiando un affogato al caffè?
Da circa un anno era finito in malo modo il mio primo grandissimo amore, durato così a lungo e che aveva riempito la mia vita per tanti anni. Eppure ormai lo sentivo lontanissimo e quasi dimenticato, parte di un altro mondo, di quell’infanzia durata tantissimo e improvvisamente terminata.
Quello stesso anno, in una bella giornata di primavera, era morto un amico che avevo visto crescere e con cui avevo condiviso lunghe chiacchierate, e la sua morte mi aveva riempito di rabbia e stupore perché, se pur sapevo che si può anche morire giovani, non avevo mai pensato che potesse veramente accadere. Mi sembrava terribilmente ingiusto.
E poi in estate, in una notte di tempesta, era morta mia nonna.
Nell’estate del 1976 mia nonna invece era viva, bella e giovane, tanto che tutti pensavano fosse mia madre. Arrivò una sera, in treno, in ritardo. Io e la zia la aspettammo sul ciglio della strada e la zia era spaventata e preoccupata per quel ritardo che non riusciva a capire. Stava pensando al peggio, avrebbe voluto fare qualcosa ma non sapeva cosa, per salvare la sorella a cui era sicuramente capitato qualcosa di terribile. Ascoltavo il suo sfogo, con la mano infilata nella sua, senza sapere che quella paura sarebbe stata il riflesso della mia costante paura che possa capitare qualcosa a mia sorella. Quando la nonna arrivò, l’assalì in mezzo alla strada, con tutta l’ansia e l’angoscia che aveva accumulato nell’attesa. La nonna rideva, mentre si chinava a baciarmi.
Ricordo poco del suo soggiorno, mi resta una foto di noi due sulla spiaggia, io con una maglietta a righe sopra il costume e gli zoccoli di legno e jeans, lei vestita, con una gonna rossa e una maglietta nera. La sua borsa di paglia posata accanto a noi.
Un giorno andammo a trovare una sua amica che era in vacanza con la figlia, di circa dieci anni più grande di me. Pranzammo nel loro albergo, io avevo la forchetta sporca ma mi scocciava dirlo, mi sembrava di criticare l’albergo in cui alloggiavano la signora e la figlia, quindi mangiai il primo pensando a come conservare la forchetta pulita, e fare in modo che il cameriere portasse via quella sporca.
E poi ricordo il nostro viaggio in treno, lei che alla stazione mi chiedeva: “Vuoi un leccherino?” e io che lo volevo e scelsi una caramella rettangolare e colorata, con il bastoncino, che mi stancò quasi subito e dopo mi ritrovai con il problema di dove buttarla. Viaggiammo in quarta classe, anche se avevamo biglietti di prima, perché quello fu lo scompartimento in cui salimmo e ci fermammo, sistemando le nostre cose.
Pensavo a tutto questo, mentre ero a Forte dei Marmi nel 1991, a ventun anni. Aspettavo che mi tornasse la voglia di essere felice e intanto andavo alla Capannina e poi in un altro posto in collina che si chiamava Nebraska o Nevada.
In camera leggevo Una donna spezzata della De Beauvoir e Diabolik, mentre chiuso in uno scrittoio finto-antico avevo messo il quaderno che mi ero portata e dove scrissi Madri e figlie e un altro racconto che intitolai Peter Pan.
All’improvviso mi viene voglia di ritrovare il quaderno per rileggere quel racconto e magari pubblicarlo, dopo che per anni l’avevo dimenticato non ritenendolo abbastanza bello.
“Ecco il Caffè Morin!” indico al compagno della mia vita mentre camminiamo e mi affaccio alla vetrata, stupita di ritrovare gli stessi tavolini di vimini. E’ passato tantissimo tempo eppure è rimasto uguale, identico ad allora. E’ bello trovare un posto che non è cambiato, nonostante siano passati diciannove anni. E il Caffè Morin è ancora lì, esattamente dove lo ricordavo: ci è rimasto per tutti questi anni, mentre io vivevo altrove.
Il compagno della mia vita dà un’occhiata distratta, il Caffè Morin non sembra impressionarlo più di tanto.
Eppure io adesso vorrei ritrovare il mio albergo e invece non riesco proprio a ricordarmi il nome.
Cerco sulla rubrica del cellulare il numero dell’ex Polanskaya, l’unico tra gli amici di quell’estate che non si sia perso nella notte dei tempi.
Mi risponde dalla piscina dietro casa sua con voce allegra.
“Il nostro albergo non esiste più da diec’anni!” mi informa. “L’ha comprato Bocelli e adesso è diventato la casa di Bocelli.”
Ci sono rimasta male. Il nostro albergo non c’è più e mi viene in mente il giardino dove a volte alla sera ci fermavamo a parlare. Una sera, non so perché, parlammo di Cesare Pavese e la madre di un nostro amico affermò, come se fosse una verità ovvia e risaputa, che Pavese si suicidò perché era impotente. Quell’affermazione mi diede fastidio e me lo dà ancora a distanza di tempo. Più che altro mi diede fastidio la sua sicurezza, l’intolleranza verso qualunque obiezione a questo fatto. Che ne sapeva di Pavese? Se era impotente o non era impotente, non ci era dato saperlo e non mi sembrava nemmeno fosse particolarmente importante. “Non fate troppi pettegolezzi”, aveva semplicemente scritto prima di “bruciarsi dietro le navi”.
Ho chiesto all’ex Polanskaya un posto dove mangiare.
“E’ problematico, si rischia di spendere tanto e di mangiare male,” ha detto pensieroso. Poi gli è venuto in mente un bagno dove si può mangiare bene senza spendere molto. “Vai verso nord,” mi ha detto.
“Verso nord???? Ma se io nemmeno so dov’è il nord?”
L’ex Polanskaya ha sospirato dall’altra parte del telefono.
“Tieni il mare sulla sinistra,” ha detto.
Abbiamo tenuto il mare sulla sinistra per un po’, camminando sotto il sole.
“Sai che in una giornata come questa, in luglio, dopo essere tornata dalla spiaggia, ho mangiato per la prima volta l’ossobuco col risotto?” ho detto ridendo. Anche il compagno della mia vita ha riso.
Ebbene sì, la storia d’amore tra me, l’ossobuco e il risotto è iniziata proprio qui, sotto il sole caldo della una, grazie all’amore della zia per la cucina. In quell’estate scoprii anche la pasta col pesto e i solitaire, che la zia faceva alla sera e per gran parte della notte prima di addormentarsi. Anch’io imparai due solitari, quello dei re e l’orologio.
E poi c’era la gazzosa, consumata sulla chaise longue prima di tornare a casa per pranzo.
“Fa troppo caldo, fermiamoci da qualche parte,” dice il compagno della mia vita che di Forte dei Marmi sembra ormai averne abbastanza.
“Torniamo al Caffè Morin,” dico e già mi torna in mente il sapore del gelato alla crema affogato nel caffè. E poi anch’io sono stufa di questo sole a picco sulla testa e ho voglia dell’ombra del patio fresco, con i tavolini di vimini.
Torniamo indietro, ci accoglie sorridendo un cameriere che forse nel 1991 non era ancora nato e che mi informa che ora hanno solo gelati confezionati. Delusione! Non riesco a crederci, lo dico in un sms indignato all’ex Polanskaya.
Mangio velocemente una caprese di plastica, poi torniamo fuori e questa volta percorriamo un viale alberato e ombroso. Ricordo quel viale, da qualche parte, nella mia memoria, c’è anche lui.
Finalmente arriviamo in centro e finalmente anche il compagno della mia vita sembra apprezzare un po’ di più questo paese dove probabilmente non vorrà più saperne di tornare.
Gli indico la piazza dove nel 1976 c’erano i baracchini con le paperette di plastica e noi bambini cercavamo di prenderle con il bastone per trovare la sorpresa. Anche il compagno della mia vita ha un ricordo d’infanzia con paperette di plastica. Forse ce l’hanno tutti quelli che, come noi, sono stati bambini negli anni Settanta.
Una volta, con la zia, prendemmo anche la carrozzella, incitavamo il cavallo ad andare più veloce e il cocchiere decise di accontentarci e lo spronò con la frusta. La zia lanciò un urlo.
“Non farlo imbizzarrire!” strillò.
Chissà perché l’idea che il cavallo diventasse bizzarro mi fece ridere a lungo e anche adesso, mentre lo racconto, rido ancora.
Un vigile in bicicletta ci passa davanti.
“Andiamo,” dice il compagno della mia vita, “ci scade il parcheggio.”
Ripercorriamo il viale alberato e torniamo verso la Capannina. Sono sempre entrata gratis, avrei dovuto apprezzare il privilegio, invece ogni volta, mentre ero lì davanti, speravo che quella sera ci rimbalzassero, così me la sarei risparmiata. L’avesse saputo l’ex Polanskaya! No, questo non posso dirglielo, nemmeno diciannove anni dopo.
Davanti a noi sfrecciano due tizi su due monopattini motorizzati con i manubri. Li guardo incuriosita, mentre il compagno della mia vita scuote la testa.
“Tutte le cazzate le hanno qui,” dice.
Saliamo in macchina e per fortuna non è bollente perché è rimasta al riparo degli alberi.
Procediamo lungo la strada senza uscita, piano, alla ricerca di un punto dove poter fare inversione. Quando lo troviamo e ci fermiamo, il furbone dietro di noi si ferma a due centimetri dalla nostra auto, impedendoci di fare manovra.
“Tutti i deficienti sono qui,” dice il compagno della mia vita, quasi rassegnato.
Dopo qualche minuto di incertezza, il furbone capisce, fa marcia indietro e ci lascia lo spazio necessario ad effettuare la manovra.
“Noi andavamo sempre in bicicletta,” dico e gli racconto di quando andavamo fino a Marina di Pietrasanta e l’amico che era con me, che lui ha conosciuto e che ora non vediamo da parecchi anni, ha fatto un frontale con un vecchietto.
Invece una sera siamo andati al cinema all’aperto a vedere Ghost (o forse era Pretty Woman) e un tizio in bicicletta ha puntato Polanskaya, che è scappato di corsa sul marciapiede, spaventatissimo. Ma forse non l’ha puntato davvero, forse se l’è immaginato lui e si è spaventato per niente.
“Eravate perfettamente integrati nello spirito del luogo,” sogghigna il compagno della mia vita, mentre soddisfatto dirige l’auto verso l’autostrada.
A Marina di Pietrasanta Polanskaya ci andava spesso, si recava alla Versiliana e, quando tornammo a Milano, quelle sue frequentazioni estive ci fruttarono un invito ad una trasmissione televisiva, dove sfoggiammo una bruttissima figura perché fummo inquadrati in un momento in cui era completamente evidente il nostro disinteresse e la noia per quella trasmissione.
E poi una volta il nostro amico del frontale scoprì una porta comunicante tra la loro camera e quella di un misterioso vicino, entrò dall’altra parte e ci nascose una scarpa di Polanskaya. Lo scherzo però non riuscì perché né Polanskaya né il vicino si accorsero e il nostro amico tornò deluso nell’altra stanza a recuperare la scarpa.
Sorrido mentre guardo il paese che si allontana. Impossibile scoprire dov’era la casa della zia.
Cerco nella borsa ed estraggo il blocco
“Cosa fai adesso?” chiede il compagno della mia vita.
“Scrivo un racconto.”
E’ stato quindi mentre cenavo e guardavo i mondiali, osservavo gli omini blu che rincorrevano la palla vicino alla porta avversaria e poi cercavano di allontanarla dalla propria, che mi sono ricordata di quel pomeriggio lontanissimo in cui ero una bambina che giocava a palla con altri bambini, nel giardino della casa di mia zia.
Ad un certo punto avevamo smesso di giocare e io ero entrata in casa, trovando il soggiorno immerso nella penombra e in un silenzio assoluto, che mi intimidiva e mi infastidiva, mentre tutti fissavano la televisione.
“Vieni,” bisbigliò mia madre prendendomi in braccio e sfiorandomi il viso con i suoi capelli neri lunghi, mentre mi faceva sedere sulle ginocchia. “Guarda, quelli azzurri sono i nostri omini, vedi che corrono e cercano di avvicinarsi alla porta degli altri? Devono buttare dentro la palla,” mi disse, spiegandomi così le poche nozioni che aveva di calcio e che sono tuttora le poche che ho io.
Ho scoperto solo molti anni dopo che erano i mondiali del ‘74 e che l’Italia non ne uscì per niente bene. Questo in parte spiega la sensazione che il silenzio di quel giorno fosse non solo concentrato ma anche piuttosto irritato.
Il resto del weekend invece non andò così male, la casa che mia zia aveva affittato aveva parecchie stanze e in ogni stanza c’era un campanello, il cui numero appariva su una specie di monitor in cucina, cosa che mi divertiva molto e che era una fonte continua di nuovi giochi. Uno su tutti quello dell’ospedale.
Ritornai in quella casa due anni più tardi, in luglio, per due lunghe settimane che restano uno dei periodi più allegri e felici della mia infanzia.
Partii con la zia all’alba di una mattina in cui le strade di Milano erano deserte e il radiotaxi correva veloce verso la stazione centrale. Gli amici che dovevano partire con noi e con i quali dovevamo dividere la casa, arrivarono invece tranquillamente, un buon quarto d’ora più tardi, rilassati e sorridenti.
“Buongiorno!” dissero continuando a sorridere, mentre erano ancora sulla scala mobile.
“Buongiorno un corno!” li accolse irritata la zia.
Quello fu l’inizio della vacanza e della convivenza.
“Voglio andare a Forte dei Marmi,” ho detto, mentre cenavo e guardavo la terribile partita dell’Italia, senza capire niente se non che gli omini blu dovevano cercare di avvicinarsi il più possibile alla porta avversaria e spingere dentro la palla.
Il compagno della mia vita ha staccato gli occhi dalla televisione per un secondo, giusto il tempo di lanciarmi un’occhiata stupita, chiedendosi perché mai mi fosse venuto in mente Forte dei Marmi mentre era in corso una schifosissima partita, che la nostra squadra stava anche rischiando di perdere. Credo che niente potesse essere più lontano dalla sua mente di Forte dei Marmi, un paese dove non era mai stato e dove nemmeno aveva voglia di andare. Del resto anch’io non andavo a Forte dei Marmi da vent’anni. Diciannove per l’esattezza, visto che l’ultima volta è stata in quel bruttissimo e lontano 1991. Diciannove anni… lo stavo realizzando solo adesso e mi chiedevo anche perché fossi stata così tanto tempo senza tornarci. Eppure è un posto dove sono stata felice, anche nel 1991 a Forte dei Marmi ero stata bene. E mi è capitato di passarci spesso, in questi diciannove anni. Invece niente, gli anni sono passati e non mi sono mai fermata. Ci sono parecchie cose di cui mi sto accorgendo che non faccio da secoli senza sapere il perché. Forse semplicemente perché questi anni sono passati molto velocemente, troppo velocemente, e io non ho fatto in tempo.
E’ stato così che siamo passati da Forte dei Marmi e siamo usciti dall’autostrada, in una domenica caldissima, mentre il navigatore ci dirige con voce imperiosa verso il centro e ci porta dritti davanti alla Capannina. E vista così, diciannove anni dopo, di giorno, con il sole, la Capannina mi sembra improvvisamente bella e allegra.
Perché in realtà la Capannina è uno dei posti in cui mi sono annoiata di più in vita mia, ricordo ancora quell’orribile sonno che mi assaliva mentre mi trascinavo da un tavolo all’altro, da una sala all’altra. Ogni volta che sono stata alla Capannina desideravo la mia camera d’albergo e il mio comodo letto e mi chiedevo quanto tempo sarebbe passato prima di poterci andare, mentre accanto a me i miei amici sorridevano e si rallegravano per il privilegio di esser entrati gratis anche quella sera.
Preferivo di gran lunga il Caffè Morin, con i suoi divanetti di vimini e l’affogato al caffè che mi sembrava insuperabile.
“Adesso mi prendo subito una polanskaya,” sorrideva felice uno dei miei amici, che per quell’estate venne soprannominato Polanskaya. Ne beveva a litri, di polanskaya, che altro non era se non un miscuglio di vodka, limone e zucchero. Lo guardavo nauseata e mi veniva ancora più sonno e ancora più voglia di affogato al caffè.
Lo racconto al compagno della mia vita e imito la voce del mio amico, mentre calca l’accento sul nome russo.
Il compagno della mia vita sorride e guarda con sufficienza la Capannina.
“Non mi ricordo più dov’era il nostro albergo,” dico. A dire la verità non mi ricordo nemmeno più il nome, sono secoli che non ci penso. “Però mi ricordo che qui vicino c’era il Caffè Morin, mi piacerebbe tornarci, facevano un affogato al caffè buonissimo. Potremmo prenderci un gelato per pranzo…” dico. Se solo mi ricordassi dov’è il Caffè Morin!
Fa un caldo terribile sul lungomare, sotto il sole. E il lungomare in realtà è la parte che mi interessa meno, io vorrei girare per il paese e ritrovare le strade dove ho camminato tanti anni fa. E’ strano, quell’estate, nel 1991, cercavo i luoghi dov’ero stata da bambina, guardavo all’interno di ogni giardino per ritrovare la casa della zia, mentre ora vorrei ritrovare l’albergo e i luoghi di allora, quando avevo ventun anni ed ero arrivata a Forte dei Marmi con tutta la tristezza di quel brutto anno e la voglia di lasciarmela alle spalle.
Ma cosa cercavo quell’estate, a ventun anni, mentre sedevo ad un tavolo di vimini del Caffè Morin, mangiando un affogato al caffè?
Da circa un anno era finito in malo modo il mio primo grandissimo amore, durato così a lungo e che aveva riempito la mia vita per tanti anni. Eppure ormai lo sentivo lontanissimo e quasi dimenticato, parte di un altro mondo, di quell’infanzia durata tantissimo e improvvisamente terminata.
Quello stesso anno, in una bella giornata di primavera, era morto un amico che avevo visto crescere e con cui avevo condiviso lunghe chiacchierate, e la sua morte mi aveva riempito di rabbia e stupore perché, se pur sapevo che si può anche morire giovani, non avevo mai pensato che potesse veramente accadere. Mi sembrava terribilmente ingiusto.
E poi in estate, in una notte di tempesta, era morta mia nonna.
Nell’estate del 1976 mia nonna invece era viva, bella e giovane, tanto che tutti pensavano fosse mia madre. Arrivò una sera, in treno, in ritardo. Io e la zia la aspettammo sul ciglio della strada e la zia era spaventata e preoccupata per quel ritardo che non riusciva a capire. Stava pensando al peggio, avrebbe voluto fare qualcosa ma non sapeva cosa, per salvare la sorella a cui era sicuramente capitato qualcosa di terribile. Ascoltavo il suo sfogo, con la mano infilata nella sua, senza sapere che quella paura sarebbe stata il riflesso della mia costante paura che possa capitare qualcosa a mia sorella. Quando la nonna arrivò, l’assalì in mezzo alla strada, con tutta l’ansia e l’angoscia che aveva accumulato nell’attesa. La nonna rideva, mentre si chinava a baciarmi.
Ricordo poco del suo soggiorno, mi resta una foto di noi due sulla spiaggia, io con una maglietta a righe sopra il costume e gli zoccoli di legno e jeans, lei vestita, con una gonna rossa e una maglietta nera. La sua borsa di paglia posata accanto a noi.
Un giorno andammo a trovare una sua amica che era in vacanza con la figlia, di circa dieci anni più grande di me. Pranzammo nel loro albergo, io avevo la forchetta sporca ma mi scocciava dirlo, mi sembrava di criticare l’albergo in cui alloggiavano la signora e la figlia, quindi mangiai il primo pensando a come conservare la forchetta pulita, e fare in modo che il cameriere portasse via quella sporca.
E poi ricordo il nostro viaggio in treno, lei che alla stazione mi chiedeva: “Vuoi un leccherino?” e io che lo volevo e scelsi una caramella rettangolare e colorata, con il bastoncino, che mi stancò quasi subito e dopo mi ritrovai con il problema di dove buttarla. Viaggiammo in quarta classe, anche se avevamo biglietti di prima, perché quello fu lo scompartimento in cui salimmo e ci fermammo, sistemando le nostre cose.
Pensavo a tutto questo, mentre ero a Forte dei Marmi nel 1991, a ventun anni. Aspettavo che mi tornasse la voglia di essere felice e intanto andavo alla Capannina e poi in un altro posto in collina che si chiamava Nebraska o Nevada.
In camera leggevo Una donna spezzata della De Beauvoir e Diabolik, mentre chiuso in uno scrittoio finto-antico avevo messo il quaderno che mi ero portata e dove scrissi Madri e figlie e un altro racconto che intitolai Peter Pan.
All’improvviso mi viene voglia di ritrovare il quaderno per rileggere quel racconto e magari pubblicarlo, dopo che per anni l’avevo dimenticato non ritenendolo abbastanza bello.
“Ecco il Caffè Morin!” indico al compagno della mia vita mentre camminiamo e mi affaccio alla vetrata, stupita di ritrovare gli stessi tavolini di vimini. E’ passato tantissimo tempo eppure è rimasto uguale, identico ad allora. E’ bello trovare un posto che non è cambiato, nonostante siano passati diciannove anni. E il Caffè Morin è ancora lì, esattamente dove lo ricordavo: ci è rimasto per tutti questi anni, mentre io vivevo altrove.
Il compagno della mia vita dà un’occhiata distratta, il Caffè Morin non sembra impressionarlo più di tanto.
Eppure io adesso vorrei ritrovare il mio albergo e invece non riesco proprio a ricordarmi il nome.
Cerco sulla rubrica del cellulare il numero dell’ex Polanskaya, l’unico tra gli amici di quell’estate che non si sia perso nella notte dei tempi.
Mi risponde dalla piscina dietro casa sua con voce allegra.
“Il nostro albergo non esiste più da diec’anni!” mi informa. “L’ha comprato Bocelli e adesso è diventato la casa di Bocelli.”
Ci sono rimasta male. Il nostro albergo non c’è più e mi viene in mente il giardino dove a volte alla sera ci fermavamo a parlare. Una sera, non so perché, parlammo di Cesare Pavese e la madre di un nostro amico affermò, come se fosse una verità ovvia e risaputa, che Pavese si suicidò perché era impotente. Quell’affermazione mi diede fastidio e me lo dà ancora a distanza di tempo. Più che altro mi diede fastidio la sua sicurezza, l’intolleranza verso qualunque obiezione a questo fatto. Che ne sapeva di Pavese? Se era impotente o non era impotente, non ci era dato saperlo e non mi sembrava nemmeno fosse particolarmente importante. “Non fate troppi pettegolezzi”, aveva semplicemente scritto prima di “bruciarsi dietro le navi”.
Ho chiesto all’ex Polanskaya un posto dove mangiare.
“E’ problematico, si rischia di spendere tanto e di mangiare male,” ha detto pensieroso. Poi gli è venuto in mente un bagno dove si può mangiare bene senza spendere molto. “Vai verso nord,” mi ha detto.
“Verso nord???? Ma se io nemmeno so dov’è il nord?”
L’ex Polanskaya ha sospirato dall’altra parte del telefono.
“Tieni il mare sulla sinistra,” ha detto.
Abbiamo tenuto il mare sulla sinistra per un po’, camminando sotto il sole.
“Sai che in una giornata come questa, in luglio, dopo essere tornata dalla spiaggia, ho mangiato per la prima volta l’ossobuco col risotto?” ho detto ridendo. Anche il compagno della mia vita ha riso.
Ebbene sì, la storia d’amore tra me, l’ossobuco e il risotto è iniziata proprio qui, sotto il sole caldo della una, grazie all’amore della zia per la cucina. In quell’estate scoprii anche la pasta col pesto e i solitaire, che la zia faceva alla sera e per gran parte della notte prima di addormentarsi. Anch’io imparai due solitari, quello dei re e l’orologio.
E poi c’era la gazzosa, consumata sulla chaise longue prima di tornare a casa per pranzo.
“Fa troppo caldo, fermiamoci da qualche parte,” dice il compagno della mia vita che di Forte dei Marmi sembra ormai averne abbastanza.
“Torniamo al Caffè Morin,” dico e già mi torna in mente il sapore del gelato alla crema affogato nel caffè. E poi anch’io sono stufa di questo sole a picco sulla testa e ho voglia dell’ombra del patio fresco, con i tavolini di vimini.
Torniamo indietro, ci accoglie sorridendo un cameriere che forse nel 1991 non era ancora nato e che mi informa che ora hanno solo gelati confezionati. Delusione! Non riesco a crederci, lo dico in un sms indignato all’ex Polanskaya.
Mangio velocemente una caprese di plastica, poi torniamo fuori e questa volta percorriamo un viale alberato e ombroso. Ricordo quel viale, da qualche parte, nella mia memoria, c’è anche lui.
Finalmente arriviamo in centro e finalmente anche il compagno della mia vita sembra apprezzare un po’ di più questo paese dove probabilmente non vorrà più saperne di tornare.
Gli indico la piazza dove nel 1976 c’erano i baracchini con le paperette di plastica e noi bambini cercavamo di prenderle con il bastone per trovare la sorpresa. Anche il compagno della mia vita ha un ricordo d’infanzia con paperette di plastica. Forse ce l’hanno tutti quelli che, come noi, sono stati bambini negli anni Settanta.
Una volta, con la zia, prendemmo anche la carrozzella, incitavamo il cavallo ad andare più veloce e il cocchiere decise di accontentarci e lo spronò con la frusta. La zia lanciò un urlo.
“Non farlo imbizzarrire!” strillò.
Chissà perché l’idea che il cavallo diventasse bizzarro mi fece ridere a lungo e anche adesso, mentre lo racconto, rido ancora.
Un vigile in bicicletta ci passa davanti.
“Andiamo,” dice il compagno della mia vita, “ci scade il parcheggio.”
Ripercorriamo il viale alberato e torniamo verso la Capannina. Sono sempre entrata gratis, avrei dovuto apprezzare il privilegio, invece ogni volta, mentre ero lì davanti, speravo che quella sera ci rimbalzassero, così me la sarei risparmiata. L’avesse saputo l’ex Polanskaya! No, questo non posso dirglielo, nemmeno diciannove anni dopo.
Davanti a noi sfrecciano due tizi su due monopattini motorizzati con i manubri. Li guardo incuriosita, mentre il compagno della mia vita scuote la testa.
“Tutte le cazzate le hanno qui,” dice.
Saliamo in macchina e per fortuna non è bollente perché è rimasta al riparo degli alberi.
Procediamo lungo la strada senza uscita, piano, alla ricerca di un punto dove poter fare inversione. Quando lo troviamo e ci fermiamo, il furbone dietro di noi si ferma a due centimetri dalla nostra auto, impedendoci di fare manovra.
“Tutti i deficienti sono qui,” dice il compagno della mia vita, quasi rassegnato.
Dopo qualche minuto di incertezza, il furbone capisce, fa marcia indietro e ci lascia lo spazio necessario ad effettuare la manovra.
“Noi andavamo sempre in bicicletta,” dico e gli racconto di quando andavamo fino a Marina di Pietrasanta e l’amico che era con me, che lui ha conosciuto e che ora non vediamo da parecchi anni, ha fatto un frontale con un vecchietto.
Invece una sera siamo andati al cinema all’aperto a vedere Ghost (o forse era Pretty Woman) e un tizio in bicicletta ha puntato Polanskaya, che è scappato di corsa sul marciapiede, spaventatissimo. Ma forse non l’ha puntato davvero, forse se l’è immaginato lui e si è spaventato per niente.
“Eravate perfettamente integrati nello spirito del luogo,” sogghigna il compagno della mia vita, mentre soddisfatto dirige l’auto verso l’autostrada.
A Marina di Pietrasanta Polanskaya ci andava spesso, si recava alla Versiliana e, quando tornammo a Milano, quelle sue frequentazioni estive ci fruttarono un invito ad una trasmissione televisiva, dove sfoggiammo una bruttissima figura perché fummo inquadrati in un momento in cui era completamente evidente il nostro disinteresse e la noia per quella trasmissione.
E poi una volta il nostro amico del frontale scoprì una porta comunicante tra la loro camera e quella di un misterioso vicino, entrò dall’altra parte e ci nascose una scarpa di Polanskaya. Lo scherzo però non riuscì perché né Polanskaya né il vicino si accorsero e il nostro amico tornò deluso nell’altra stanza a recuperare la scarpa.
Sorrido mentre guardo il paese che si allontana. Impossibile scoprire dov’era la casa della zia.
Cerco nella borsa ed estraggo il blocco
“Cosa fai adesso?” chiede il compagno della mia vita.
“Scrivo un racconto.”