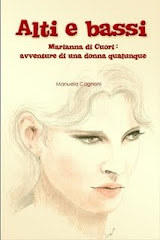«Ci vestiamo per spogliarci. Un abito è davvero un abito solo quando un uomo ha voglia di potervelo togliere.»
Ho scoperto stamattina, mentre facevo colazione, che questa frase di Françoise Sagan è stata alla base del litigio tra la Murgia e lo psicologo Morelli. È una frase che conosco bene perché è scritta sulla quarta di copertina di un piccolo libro, "Il tubino nero", una raccolta di articoli scritti per Vogue, che ho trovato anni fa alla Rizzoli. È una frase che adesso scopro essere stata definita superata e sessista. Sessista, riferito alla Sagan, ho dovuto rileggerlo un po' di volte, prima di rassegnarmi che era proprio vero. E forse qui bisognerebbe fare lo sforzo di andare oltre quella frase sulla quarta di copertina e leggere il libro, che è davvero breve, ma in cui c'è tantissimo. Soprattutto c'è lo sguardo ironico di una scrittrice che ha sempre raccontato la vita in modo leggero, ma proprio per questo terribilmente profondo. E anche questo libro, che parla di abiti, di moda, che è un gioco, parla in realtà della vita, del suo modo di vederla e di viverla. Soprattutto bisognerebbe leggere il capitolo sul riso, sull'incapacità di prendersi sul serio anche quando il successo di "Bonjour tristesse" la travolse, a diciotto anni («...la mia famiglia che, da quando avevo dodici anni, cambiava direzione nei corridoi vedendomi munita di fogli, perché leggevo le mie tragedie alla prima vittima abbastanza debole o abbastanza stanca da non evitarmi, la mia famiglia nel mio primo romanzo non vide altro che le mie fantasticherie e i miei slanci intellettuali più recenti.» «Oggi so che senza la mia famiglia avrei forse acquisito una di quelle discrete ma infedettibili auto-ammirazioni che cullano certi autori...»). Forse allora si riuscirebbe a capire quanto ci siamo appesantiti e intristiti, quanto, senza saperlo, siamo diventati simili al suo personaggio più bello, Antoine, il protagonista de "La disfatta", nel momento in cui diventa un po' meno bello, un po' troppo compreso in se stesso, con «la tendenza ad ascoltarsi parlare.»