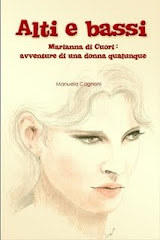Ci sono libri che rendono felici solo per il fatto di stare nella borsa e aspettare il momento in cui avremo tempo di leggerli. Ed è così anche se è lunedì e ti sei svegliata alle 6.30 e piove a dirotto.
In effetti è stato in un tardo pomeriggio d'autunno che ho incontrato Heinrich Heine. Era l'anno della maturità, circa dodici mesi prima della caduta del muro di Berlino, quando la Germania era ancora divisa in due, e dalle pagine del libro di letteratura tedesca apparve il poeta di Düsseldorf, ugualmente detestato e volutamente ignorato da entrambe le parti.
Eppure quella sera, mentre leggevo la sua vita, le sue poesie, i suoi aforismi, mi parve talmente vicino a me e alla malinconia dell'autunno che mai più sarei riuscita a liberarmi di lui. Heine per me è la quintessenza della letteratura. È noto soprattutto come poeta, perché le poesie sono riuscite in qualche modo a sfuggire alla damnatio memoriae operata dai suoi connazionali, ma è stato anche scrittore, giornalista, saggista, critico. Non c'è ramo della letteratura in cui non abbia prestato il suo contributo, con la ricchezza della sua arte, pervasa di delusione, amarezza, ma sempre ironica e capace di strappare un sorriso nel momento in cui il lettore meno se l'aspetta.
Per qualche tempo girai per le librerie cercando i suoi libri. Mi andava bene qualsiasi cosa, volevo soltanto andare oltre i brani riportati sui libri di letteratura. Ma i commessi delle librerie mi guardavano perplessi. Non conoscevano quel nome, anche se apparteneva ad un poeta paragonabile a Goethe. "Con l'eccezione di Goethe," scrive Marcel Reich Ranicki, "a nessun singolo lirico tedesco è toccata una popolarità anche solo approssimativamente vasta quanto la sua".
Poi finalmente un giorno, per caso, mi ritrovai davanti "Notti fiorentine". Frammento, racconto in prosa che forse più di ogni altro rappresenta il suo autore, mescolando aspetti onirici e gotici a cronache della vita del tempo. L'ho riletto in questi giorni, insieme a "Memorie di Schnabelewopski", perché cercavo una citazione, perché era passato tanto tempo, o forse, semplicemente, perché rileggere i suoi scritti è sempre come leggere qualcosa di nuovo. Perché Heine è soprattutto l'autore dei contrasti, la cui arte è impossibile da definire, tanto che Laura Mancinelli dà la colpa a questa complessità della sua opera se su di lui è caduto un macigno di silenzio. Eppure credo che nessun autore abbia saputo farsi amare così tanto e trasmettere altrettante emozioni attraverso il tempo. "L'ho sentito al mio fianco alla stregua di mio contemporaneo e alleato, di amico geniale, anche se talvolta un po' inaffidabile," scrive ancora Marcel Reich Ranicki. È successo a lui, a Sissi e anche a me.
In effetti è stato in un tardo pomeriggio d'autunno che ho incontrato Heinrich Heine. Era l'anno della maturità, circa dodici mesi prima della caduta del muro di Berlino, quando la Germania era ancora divisa in due, e dalle pagine del libro di letteratura tedesca apparve il poeta di Düsseldorf, ugualmente detestato e volutamente ignorato da entrambe le parti.
Eppure quella sera, mentre leggevo la sua vita, le sue poesie, i suoi aforismi, mi parve talmente vicino a me e alla malinconia dell'autunno che mai più sarei riuscita a liberarmi di lui. Heine per me è la quintessenza della letteratura. È noto soprattutto come poeta, perché le poesie sono riuscite in qualche modo a sfuggire alla damnatio memoriae operata dai suoi connazionali, ma è stato anche scrittore, giornalista, saggista, critico. Non c'è ramo della letteratura in cui non abbia prestato il suo contributo, con la ricchezza della sua arte, pervasa di delusione, amarezza, ma sempre ironica e capace di strappare un sorriso nel momento in cui il lettore meno se l'aspetta.
Per qualche tempo girai per le librerie cercando i suoi libri. Mi andava bene qualsiasi cosa, volevo soltanto andare oltre i brani riportati sui libri di letteratura. Ma i commessi delle librerie mi guardavano perplessi. Non conoscevano quel nome, anche se apparteneva ad un poeta paragonabile a Goethe. "Con l'eccezione di Goethe," scrive Marcel Reich Ranicki, "a nessun singolo lirico tedesco è toccata una popolarità anche solo approssimativamente vasta quanto la sua".
Poi finalmente un giorno, per caso, mi ritrovai davanti "Notti fiorentine". Frammento, racconto in prosa che forse più di ogni altro rappresenta il suo autore, mescolando aspetti onirici e gotici a cronache della vita del tempo. L'ho riletto in questi giorni, insieme a "Memorie di Schnabelewopski", perché cercavo una citazione, perché era passato tanto tempo, o forse, semplicemente, perché rileggere i suoi scritti è sempre come leggere qualcosa di nuovo. Perché Heine è soprattutto l'autore dei contrasti, la cui arte è impossibile da definire, tanto che Laura Mancinelli dà la colpa a questa complessità della sua opera se su di lui è caduto un macigno di silenzio. Eppure credo che nessun autore abbia saputo farsi amare così tanto e trasmettere altrettante emozioni attraverso il tempo. "L'ho sentito al mio fianco alla stregua di mio contemporaneo e alleato, di amico geniale, anche se talvolta un po' inaffidabile," scrive ancora Marcel Reich Ranicki. È successo a lui, a Sissi e anche a me.