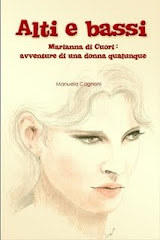"A volte ho in mente un lettore anti-Roth. 'Quanto odierà questa cosa,' penso. Ed è tutto l'incoraggiamento di cui ho bisogno".
Ho pensato molto a queste parole mentre leggevo. Ci ho pensato soprattutto quando Sabbath frugava nei cassetti della biancheria della moglie e della figlia del suo migliore amico; ci ho pensato mentre, nel mezzo di Manhattan, sbottonava la camicetta a una ragazza per palparle il seno; ci ho pensato mentre profanava la tomba di Drenka, l'amante defunta. "Nei capolavori tutti vogliono sempre suicidarsi quando commettono adulterio. Lui voleva suicidarsi quando non poteva commetterlo".
Ma io non appartengo a quei lettori che incoraggiano Roth, perché a me Sabbath piace moltissimo. Soprattutto mi piace che questo romanzo sia stato scritto nel 1995, una vita fa, un mondo fa, ma che da quel mondo Roth sia riuscito a parlare così bene del nostro mondo, delle nostre ipocrisie, delle nostre pietre, messe sopra tutto quello che non vogliamo vedere. "I tuoi amici hanno una registrazione della mia voce che rende reali tutte le cose peggiori che vogliono che il mondo sappia sugli uomini".
Perché Sabbath non è il peggio, come lui stesso scopre con delusione e disappunto, quando va a trovare la sua seconda moglie in una clinica psichiatrica. Il peggio è qualcosa di più profondo, qualcosa che sta sotto quelle facciate perbene, sotto la maschera di un professore dallo sguardo severo. Il peggio sta in quei matrimoni perfetti, tra persone di successo, che si detestano e che sognano di andarsene. "Poi hanno sessant'anni, sessantacinque, settanta, e che differenza fa, ormai? Se ne andranno, certo. Per alcune persone questa è la cosa migliore da dire sulla morte: finalmente fuori dal matrimonio. E senza doversi rifugiare in un hotel. Senza dover vivere quelle miserabili domeniche da soli in un hotel. Sono le domeniche a tenere insieme queste coppie. Come se niente fosse peggiore delle domeniche da soli."
"Il teatro di Sabbath" è soprattutto un libro sulla solitudine, il protagonista è infatti "nel periodo di maggior solitudine della sua vita", quello in cui a volte pensa al suicidio, ma poi "capita sempre qualcosa che ti costringe ad andare avanti a vivere". E' la solitudine di chi rimane, circondato dai fantasmi di quelli che se ne sono andati, prima di tutti la madre, una madre adesso onnipresente, che guarda, giudica e dà consigli. Quella stessa madre che in realtà è morta molto tempo prima, insieme al figlio maggiore Morty ("Ma lui non è morto perché era ebreo. È morto perché era americano. L'hanno ucciso perché era nato in America"). Le pagine sui genitori e su Morty, il fratello maggiore, il modello che Sabbath si sforza invano di sostituire, sono le più belle. Sono queste infatti le pagine in cui emerge il suo lato più umano e più fragile: il dispiacere per la morte del fratello, i tentativi di essere come lui, di riuscire a sostituirlo, la consapevolezza di non poterlo fare. E poi la disgregazione della famiglia, la perdita dei genitori quando ancora sono vivi, l'incapacità di dare vita lui stesso a una famiglia ("mai benedetto da figli"). Non con Nikki, la prima moglie, la bellissima greca che veste sempre in bianco e nero, l'attrice "di cui non si sa più nulla" (sì, tra le pagine di questo romanzo Shakespeare sbuca di continuo), cercata e aspettata inutilmente. Non con Roseanna, la moglie che Sabbath tradisce e con cui ha tradito Nikki. Ma nella vita di Sabbath, ad un certo punto, è arrivata Drenka, il suo alter ego, l'immigrata croata, che come lui è sposata e ha altri amanti, eppure è sempre felice di condividere e mettere in pratica le sue fantasie. E quando si parla della presunta misoginia di Roth bisognerebbe pensare soprattutto a Drenka, personaggio femminile con gli stessi difetti e le stesse qualità di quelli maschili. E forse anche questo dà parecchio fastidio al lettore anti-Roth.